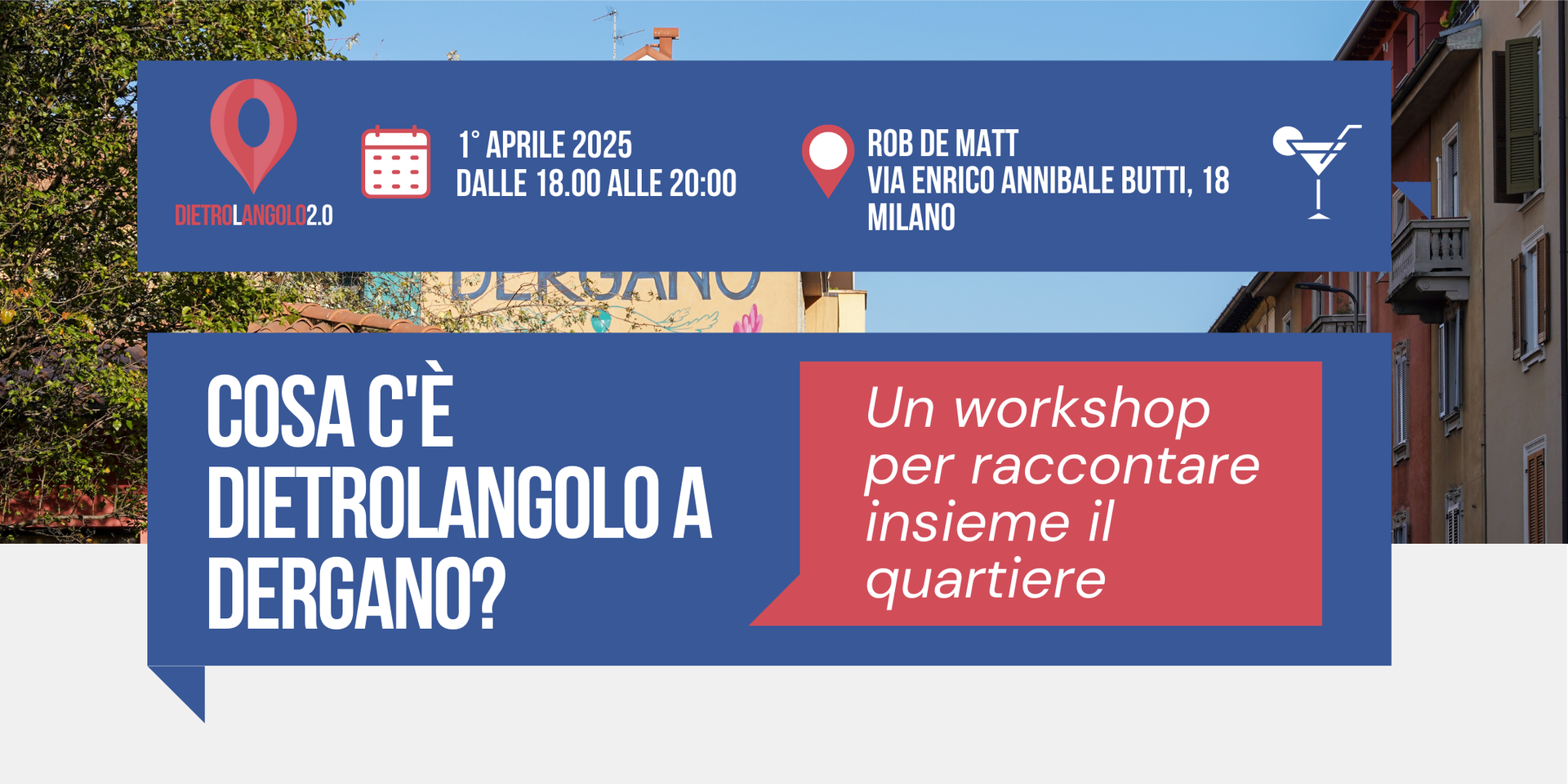Vivere nelle case di Sant'Erlembardo
Il complesso, che è stato realizzato nel 1939 dalla Fondazione Crespi-Morbio con oltre 180 appartamenti, è stato un vero e proprio esempio di sperimentazione edilizia e architettonica
Incontriamo Adele che, con la sua famiglia, ha abitato nel complesso di Sant'Erlembardo, costruito per volere della Contessa Crespi.
Sono venuta al mondo in una famiglia numerosa. Prima di me c’erano già sei fratelli; dopo è nata ancora un’ottava sorella.
Abitavamo nelle case popolari di Sant’Erlembardo, un quartiere per famiglie numerose cui erano ammessi nuclei con almeno cinque figli, realizzato nel 1939 dalla Fondazione Crespi-Morbio, con oltre 180 appartamenti.
Il complesso, chiaramente distinguibile per la mole dei suoi edifici, è caratterizzato da un grande rilievo laterale (una madre con due bambini).
Le case avevano ampi spazi collettivi e cantine-rifugio per i bombardamenti aerei.
Io lì stavo bene da bambina: avevamo le suore e ci tenevano quando i genitori erano occupati o al lavoro. Appena cominciata la scuola eravamo tutti assieme, ma, cresciuto il numero degli alunni, poiché la scuola Crispi non aveva sufficienti aule per ospitarci tutti, sono stati organizzati due turni.
Io frequentavo la scuola di pomeriggio dopo aver usufruito della mensa. La mattina stavo con le suore. Questo mi ha salvato dalla bomba, caduta di mattino sulla scuola.
Nel complesso di Sant’Erlembardo avevamo a disposizione tre enormi saloni condivisi, che usavamo per riunirci, suddivisi per età. I più piccoli avevano uno spazio dove giocare d’inverno o con la pioggia. I più grandi avevano a disposizione laboratori per imparare un mestiere, come la scuola di cucito. C’era anche una scuola di musica – guidata dalla mitica signorina Nason.
Gli inquilini venivano allocati nei vari edifici con una logica di omogeneità. Operai, impiegati, artigiani, in modo da creare comunità con orari e attitudini comuni.
La contessa Crespi passava parecchio tempo a Sant’Erlembardo. Per le ricorrenze portava doni per noi bambini. Conosceva tutte le famiglie e aiutava le più indigenti. È stata una grande benefattrice. Ricordo che chi aveva bisogno prendeva appuntamento in corso Venezia e veniva accolto e ascoltato.
Il nostro appartamento aveva tre grandi camere da letto, un soggiorno, una cucina (piccola) e un bagno.
All’epoca la gente abitava ancora nelle cascine, con i servizi igienici in cortile o in case di ringhiera. Noi ci sentivamo dei privilegiati, anche perché gli ambienti erano ariosi.
All’inizio non avevamo riscaldamento: solo stufe. Ricordo che nel muro orientato a nord, in inverno, quando c’erano gelate o nevicate, si formavano lastre di ghiaccio…
In viale Monza c’erano alberi ad alto fusto maestosi che, durante la guerra, sono stati abbattuti via via dagli abitanti della zona che, notte tempo, si portavano a casa il legno, per scaldarsi.
Per noi bambini e ragazzi, l’unico divertimento era l’oratorio, luogo di socialità e di svago, dove si organizzavano molte attività, come il cinema, sia al chiuso che all’aperto.